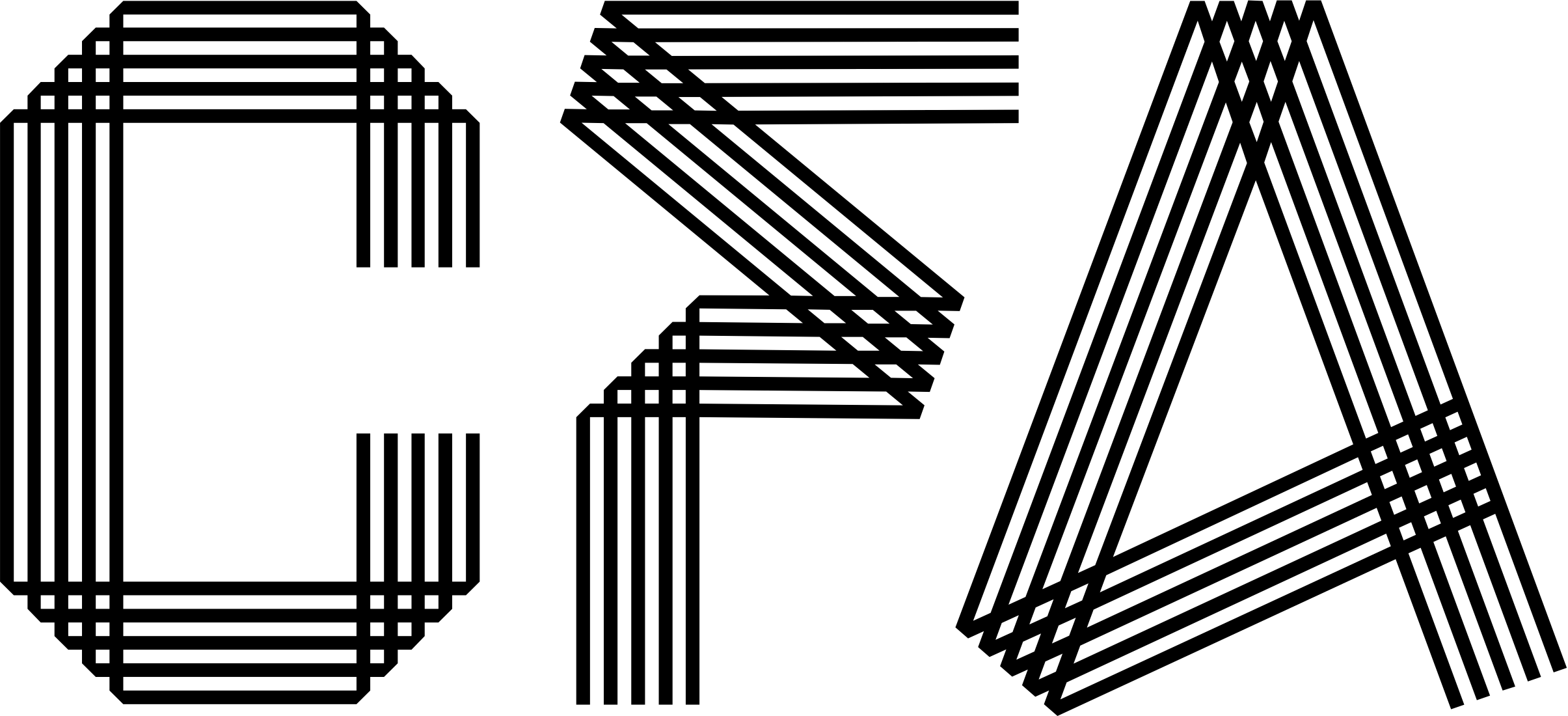Donato de’ Bardi, la “Presentazione di Gesù al tempio”
La presentazione al tempio di gesù è l’opera a partire dalla quale si è potuta ricostruire la figura di Donato de’ Bardi, grazie a Federico Zeri.
Questa Presentazione di Gesù al tempio è un’opera cardine della pittura italiana della prima metà del Quattrocento, ed è l’elemento centrale della magistrale restituzione della personalità artistica di Donato de’ Bardi compiuta da Federico Zeri nel 1973 e nel 19761. Essa è stata dipinta su di un’unica tavola di legno (pioppo?), le cui dimensioni in epoca moderna erano state leggermente alterate applicando lungo il margine inferiore un sottile listello di legno e innestando al centro del bordo superiore una piccola cimasa. Così modificata, e probabilmente inserita in una cornice di gusto rinascimentale (è solo un’ipotesi, non se ne conserva nessuna testimonianza) l’opera doveva apparire come una piccola pala autonoma, di misure più che mediane. Tenendo conto del soggetto raffigurato, Zeri rimarcava tuttavia che «resta incerto se fosse nata quale parte di una serie evangelica, di un’ancona, o piuttosto quale elemento singolo ed isolato, una possibilità questa che mi lascia tuttavia molto perplesso». Nessun altro pannello che possa essere considerato complementare a questo è oggi noto; il quesito potrebbe forse essere risolto se fosse possibile accertare l’originaria collocazione o la provenienza antica dell’opera, ma allo stato attuale degli studi non si risale oltre gli anni Sessanta-Settanta del secolo scorso, quando si trovava presso la Galleria Lorenzelli di Bergamo, una delle «botteghe» più intraprendenti e vivaci nel campo della pittura antica in Italia.

Il delicato intervento di restauro di Barbara Ferriani (2007) ha riportato il dipinto alle sue dimensioni originali e restituito alla superficie pittorica la trasparenza luminosa che la vecchia vernice aveva attenuato. Si colgono ora pienamente le raffinatezze tecniche dell’esecuzione, la preziosa finitezza delle rifiniture in oro dei bordi delle vesti e delle aureole, semitrasparenti e a raggiera, e la definizione tanto minuta dei tratti dei volti e delle pieghe dei tessuti da trarre in inganno, quanto alle sue reali dimensioni, chi conosceva il dipinto solo da una riproduzione fotografica, non dal vero. La riflettografia eseguita in occasione del restauro ha messo in evidenza il tracciato nitido ed energico del disegno sottostante, applicato direttamente sulla preparazione gessosa senza pentimenti rilevanti, particolarmente accurato nella definizione delle espressioni più marcate (quella di san Giuseppe dietro la Vergine, quelle di Simeone e della profetessa Anna alle spalle di quest’ultimo): una riprova di quanto «in Donato, a questo punto del suo svolgimento, la fonte luminosa, sebbene individuata con precisione e distribuita nei suoi riflessi con sottile dosatura, resta un fatto accessorio rispetto al dato disegnativo, preponderante ed essenziale nella definizione dell’immagine». Ad eccezione delle linee convergenti del pavimento a lastre di pietra, di cui si percepisce il tracciato a righello, l’immagine riflettografica non consente di riconoscere l’impostazione di un impianto prospettico rigoroso. Nonostante la convergenza verso un unico punto focale dei vari elementi dell’architettura, dai capitelli alle spranghe di ferro che legano gli archi, al progressivo decrescere di questi ultimi verso lo spazio absidale, il dipinto è costruito secondo una concezione empirica della prospettiva, corretta dal variare dell’intensità della luce che consente di percepire «le rispettive distanze tra figura e figura, tra persone e ambiente».

Prima della pubblicazione dello studio di Zeri nel 1973, la conoscenza di Donato de’ Bardi era limitata alla tela monumentale (238 x 165 cm) con la Crocifissione della Pinacoteca Civica di Savona, firmata su di un cartellino con i bordi accartocciati «Donatus comes bardus pa /pie[n]sis pinxit hoc opus», e sui documenti che Federico Alizeri aveva riscoperto negli archivi genovesi. Il pittore sembrava attestato per la prima volta a Genova nel 1426, poi ancora nel 1433, quando il 20 marzo di quell’anno si impegnava a dipingere per Oderigo da Cremona canonico della cattedrale di Genova (probabilmente per uno degli altari di quest’ultima) un’ancona con al centro Santa Maria Maddalena affiancata da santi e coronata dalla Crocefissione e da altre figure sacre. Di questa opera non rimane traccia, ma per l’importanza del compenso (ottanta lire di Genova) e per la sua destinazione (la cattedrale), la commissione testimonia la posizione eminente che l’artista pavese aveva raggiunto in città. Nonostante l’affermazione professionale, Donato e il fratello minore Boniforte (anch’egli pittore e di cui i documenti rivelano l’esistenza dal 1434 al 1453) devono avere conosciuto gravi difficoltà finanziarie, perché nelle carte restituite da Alizeri si succedono le suppliche indirizzate agli Anziani e al Doge per ottenere esenzioni e facilitazioni fiscali; la prima risale al 1434, che è l’anno stesso in cui cade il saldo dei pagamenti per una perduta decorazione di Palazzo San Giorgio a Genova; la seconda è del 1448, quando gli orefici genovesi intervengono a favore di Donato esaltandone l’arte e testimoniando i vantaggi che loro stessi ne traggono («quod sit utilis ministerio aurificum»); infine nel 1450 è Boniforte che con toni struggenti descrive il proprio stato miserando, lui che «nato lombardo, nobile e signore di alcune terre, ha avuto i possedimenti saccheggiati dai soldati ed ha perso tutto; per questa ragione si è trasferito nella città di Genova dove si è messo a praticare, per vivere, l’arte della pittura che prima professava per diletto; ma il fisco lo perseguita, e gli sequestra persino gli utensili domestici». Anche facendo la tara sulla retorica pietistica alla quale il pittore sembra ricorrere, il documento getta una luce sinistra sulle condizioni di lavoro a Genova nella prima metà del Quattrocento; e ciò è tanto più sorprendente in quanto il mercato e la produzione artistica della città ligure testimoniano, in questo stesso arco di tempo, una grande vivacità. Donato non è menzionato nel documento; l’ultima ricorrenza del suo nome risale al 30 giugno 1451, quando un altro pittore di Pavia, Giovanni Giorgio, promette a Giacomo Pelizzari di Pontremoli di completare una maestà con santi lasciata incompiuta dal defunto de’ Bardi.

I primi apprezzatori dell’opera di de’ Bardi disponevano quindi un solo dipinto e di una griglia documentaria assai scarsa; lo stesso Alizeri, raccordando il dipinto firmato alle testimonianze archivistiche, non nascondeva la propria ammirazione nel riconoscere nella tela di Savona uno «stile più accosto al moderno che l’epoca non comporti». Il suo apprezzamento rimase senza seguito per quasi quarant’anni, e fu Wilhelm Suida, in un’ampia e innovativa indagine sulla pittura lombarda del secolo XV, a sottolineare le non comuni qualità della Crocifissione e a rimarcarne l’impatto che questa avrebbe avuto sulla formazione artistica di Vincenzo Foppa. Al seguito della «riscoperta» di Suida, Pietro Toesca dedicherà le ultime pagine del suo monumentale volume sulla pittura e miniatura lombarde alla «grande novità di Donato de’ Bardi»; il grande storico dell’arte si interrogava su quale fosse l’origine di quelle «nuove forme» e riconosceva «nel piegar delle stoffe […] qualche influenza d’Oltralpe». Probabilmente sulla traccia degli studi di Suida e di Toesca, anche Bernard Berenson si recò nel 1912 a Savona annotando sul suo esemplare del catalogo della Pinacoteca comunale: «Extremely important transitorial master […] certainly influenced by Fra’ Angelico».
È tuttavia Roberto Longhi, in un brogliaccio dedicato al suo Maestro Raro che conosciamo grazie alla bella edizione curata da Simone Facchinetti del saggio su Carlo Braccesco, a cogliere per primo, chiaramente, la componente transalpina della Crocifissione («giova non dimenticare che l’Italia ebbe il suo Fouquet assai probabilmente proprio in Liguria nel pavese Donato de’ Bardi […]. Qualcosa che non è italiano è nel corpo di Cristo»). Anche in seguito Longhi insisterà sulle componenti nordiche di questo singolare e unico dipinto del «misterioso “Comes Papiensis”», «perché l’opera è più amica di Van Eyck e di Petrus Christus che non di Masaccio». Un giudizio confermato negli appunti stesi visitando l’esposizione riparatrice del 1946 a Genova, nella quale Antonio Morassi aveva riunito un’ottantina di dipinti antichi scelti tra quelli che erano stati rimossi dai luoghi d’origine per proteggerli dai danni della guerra: «Nel Quattrocento scade la cultura in loco. Dominano la Fiandra, La Lombardia, e il Piemonte. E vi mandano spesso pittori scadenti; però a Savona e a Genova lavorano grandi uomini; prima del ’50 Donato de’ Bardi; nell’ultimo ventennio del secolo il milanese Braccesco […] e Vincenzo Foppa». In forma più colloquiale, il giudizio è ribadito in una lettera inviata da Longhi al giovane Federico Zeri (poco prima del 4 agosto 1946) dopo avere visitato l’esposizione genovese: «Fra i quattrocentisti […] non v’è che un’opera che sia della sfera più alta: è il Donato de’ Bardi di Savona. Uno dei più grandi della prima metà del secolo». Il capolavoro di Savona rimarrà una presenza isolata ancora nella grande esposizione di Arte lombarda dai Visconti agli Sforza (1958) dove tuttavia è già messo a fuoco lo stretto legame tra il pittore pavese e Foppa: «a questa data del ’62 […] Foppa già faceva le prime escursioni in Liguria, terra di conquista per i lombardi, da quando, fin dal 1426, vi si era stabilito un misterioso pittore, il conte pavese Donato de’ Bardi. Di lui è qui la mirabile Crocefissione di Savona che, prima del ’51 (anno di morte dell’artista), indica la congiunzione più alta tra l’Italia padana e la civiltà borgognona e fiamminga di Sluter, dei Limburg e di Van Eyck».
La formulazione sintetica e in un certo senso enigmatica sembra annunciare l’imminenza di una scoperta; a dire il vero Longhi stesso l’aveva sfiorata illustrando come opera di Donato Bragadin, a cui era comunemente riferito, il trittico con la Madonna dell’Umiltà, il Bambino e i santi Filippo e Agnese del Metropolitan Museum of Art di New York accanto alla «bellissima tavoletta» della Presentazione di Gesù al tempio, «di un momento più inoltrato», e riconoscendo in entrambe la mano di un grande pittore. La grande mostra di Palazzo Reale aveva inoltre consentito confronti ed analisi illuminanti: in una sapida nota di commento Wilhelm Suida aveva visto nel Donato de’ Bardi della Crocifissione di Savona il grande precursore di Foppa, affiancandogli per stile e datazione (intorno al 1450) l’autore delle due tavole con Santo Stefano e Sant’Ambrogio della collezione Cicogna Mozzoni, che in seguito Zeri, seguendo un suggerimento di Giovanni Romano, restituirà all’ultima fase del maestro pavese.

La riflessione che ha condotto Federico Zeri al recupero della personalità di Donato de’ Bardi, nasce da questo contesto ed è legata, come è noto, alle ricerche sui dipinti italiani del Metropolitan Museum di New York, di cui oggi possiamo seguire le tappe grazie agli studi di Andrea Bacchi e di Luca Mattedi sulla sterminata corrispondenza scambiata tra lo storico dell’arte e il museo americano tra il 1948 e il 1988. Zeri firmò il contratto per la redazione del catalogo americano nel 1961, ma il volume (il quarto e ultimo della serie) in cui è pubblicata la scheda dedicata al piccolo trittico con la Madonna dell’Umiltà con il Bambino, e i santi Filippo e Agnese firmato «opus donati» (inv. 37.163.1-3), è stato edito solo nel 1986. Le ricerche sull’identità culturale del trittico risalgono tuttavia agli anni Settanta, e da un ricordo di Miklos Boskovits, che in quegli anni frequentava lo studio di Mentana, si può percepire l’inquieta tensione con la quale Zeri stava mettendo a fuoco gli elementi del suo fondamentale saggio sul de’ Bardi. L’analisi del dipinto di New York, in cui Zeri riconosceva elementi strutturali (il profilo rettangolare del trittico, privo di ornati) e formali del tutto estranei alla cultura veneziana (cui apparteneva il modesto e ritardatario Donato Bragadin) gli consentiva di sganciare il piccolo capolavoro dalla tradizionale ascrizione, e di leggervi, oltre alla straordinaria qualità dell’esecuzione, la traccia di una raffinatissima cultura oltremontana.
In effetti, al di là di un sottostrato lombardo che richiama il naturalismo espressivo di Michelino da Besozzo, il dipinto rivela una forte attrazione per la cultura franco-fiamminga: non solo nel campo della pittura su pergamena (Zeri richiamava opportunamente i due grandi fogli con Jean de Berry presentato dai santi Andrea e Giovanni Battista e la Madonna in trono con il Bambino della Biblioteca Reale di Bruxelles, inv. ms. 11060-61, estrapolati dalle Très Belles Heures de Jean de Berry, dipinti prima del 1402) ma anche in quello della scultura che, sorprendentemente, fornisce i confronti più stringenti. L’elegante figura di Agnese richiama infatti da vicino la Santa Caterina in alabastro attribuita a André Beauneveu nella chiesa di Notre-Dame a Courtrai, già parte del monumento funebre del conte Louis de Mâle (1374-1384). Alla cerchia dello scultore e miniatore di Valenciennes (doc. 1360-1400 circa) è stata inoltre riferita, a ragione, la statua di San Pietro in marmo di Candoglia del Museo del Duomo di Milano (inv. ST 104), proveniente dal pilone 83 del retrocoro della cattedrale, che rivela singolari analogie nello sviluppo dei panneggi con la figura di Filippo nel trittico americano; comune ai due santi che fiancheggiano la Madonna dell’Umiltà e alla scultura del Duomo è inoltre quella particolare misura con cui il naturalismo pacato dei volti accompagna l’elegante ed elaborato sviluppo delle vesti.

Questa particolare incidenza della cultura franco-borgognona rilevata nel dipinto del Metropolitan corrisponde ad una fase di cui non è agevole precisare l’origine né la durata. È possibile che questa componente culturale sia filtrata in Lombardia e a Genova durante il periodo in cui la Repubblica sollecitò la protezione del re di Francia (1396), e soprattutto negli anni del governatorato di Jean le Meingre, Maresciallo di Boucicaut (1401-1409) attorno al quale prese corpo una piccola corte e si svilupparono le relazioni con la Francia dei Valois, con Digione, Bourges, Parigi, Bruges. Più voci hanno inoltre richiamato il ruolo che può avere avuto in questa fase del percorso del pittore la cultura di Avignone, rappresentata dal Maestro di Thouzon e da Jacques Yverni, che intorno al 1420/1425 esegue per i marchesi di Ceva il trittico oggi alla Galleria Sabauda di Torino. La destinazione prima del trittico americano è ignota: Carl B. Strehlke lo ha messo in rapporto con il clima cosmopolita della corte viscontea di Pavia, suggerendo che i due santi raffigurati negli sportelli laterali possano alludere ai nomi di Filippo Maria Visconti e a quello della favorita Agnese del Maino. In assenza di motivi araldici, l’ipotesi è indimostrabile ma è seducente e sposterebbe, se non la manifattura, almeno la committenza del prezioso dipinto in Lombardia. A questi indizi va aggiunto un motivo iconografico di cui è difficile valutare l’impatto: la presenza di un cingolo francescano sotto il mantello della Vergine, rilevato da Zeri, ma poi lasciato cadere dallo stesso studioso e ignorato in seguito da quanti hanno analizzato il dipinto.
Il punto di partenza della ricostruzione della personalità del pittore è dunque un’opera ancora decontestualizzata. Nella fase successiva, cui appartiene la Presentazione di Gesù al tempio, il pittore rivela invece un indiscutibile aggancio territoriale: «definendo l’architettura del Tempio, egli volle conferirgli un sapore inequivocabilmente ligure: con archetti a conci alternati bianche e neri, con l’abside spoglia dalla tre strette finestrine, con le vele in azzurro cupo, interrotto dal motivo stellare, l’allusione regionale non è davvero vaga e generica. Ma, quasi a suggellare la liguricità del pannello, vanificando ogni possibile dubbio in proposito, ecco la chiave di volta che al sommo della composizione aggancia le quattro vele principali: entro il suo circolo essa reca iscritta una croce di colore rosso, lo stemma cioè della città di Genova». Anche in questo caso persistono riferimenti lombardi; «eppure il sapore ultimo di questa tavola ha qualcosa di nordico, di fiammingo; un sapore che, sia per la scena di interno, sia per luce che pervade l’ambiente, sia infine per il tono di felice, viva dignità umana che sostiene i personaggi, richiama il mondo di Jan van Eyck e di Petrus Christus».

Il clima culturale, rispetto al trittico firmato da Donato, è dunque sensibilmente cambiato, e iniziano qui a prevalere i riferimenti alla pittura fiamminga, riconoscibili anche nella presenza di alcuni specifici motivi: come il copricapo a forma di turbante che indossa Giuseppe, simile a quello che Jacques Daret raffigura nella Adorazione dei Magi della Gemäldegalerie di Berlino; o il soggolo bianco che cinge il capo della figura femminile in secondo piano, tra Maria e Giuseppe, di foggia non molto dissimile da quelli raffigurati nei ritratti femminili di Robert Campin e di Rogier van der Weyden; ed è forse più di un caso se la posa dinamica e inconsueta del Bambino teso verso la madre riproduce, in controparte, quella che compare nella Madonna con il Bambino (Madonna Durán) attribuita a van der Weyden (Madrid, Museo del Prado), divulgata tramite incisioni e disegni in un gran numero di esemplari. Il cosmopolitismo figurativo di Genova nella prima metà del secolo è oggetto di studi recenti e non è questa la sede per richiamare le opere e gli artisti che, in parallelo alla persistente presenza della pittura tardogotica senese e pisana, hanno contribuito a fare lievitare la temperatura figurativa della regione. Negli anni che precedono la metà del secolo l’influenza di Jan van Eyck, che di persona non ha mai sfiorato le coste della Liguria, e quella del linguaggio più epurato di Petrus Christus diventano preponderanti nell’arco breve di qualche anno.

Questo nuovo orientamento del gusto si legge pienamente nel grande capolavoro su tela della Crocifissione di Savona, in cui le Fiandre convivono poeticamente con le pietre astratte di Fra’ Angelico, e nei quattro Santi che Federico Zeri ha aggiunto in seconda battuta al catalogo di Donato: il San Girolamo, allora al Brooklyn Museum a New York e oggi in una collezione privata italiana, il San Giovanni Battista allora presso la Helikon Gallery di Londra e ora nella Pinacoteca di Brera; il Sant’Ambrogio e il Santo Stefano in collezione privata, che devono precedere di poco l’esecuzione della tela savonese: «per ciò che concerne la formula di cultura, il dato più valido è ancora nell’accordo lombardo-fiammingo, condotto secondo modi che, forse, consentono di orizzontarsi e di individuare il preciso punto di aggancio tra Donato e le Fiandre»: il confronto visivo tra il busto di Santo Stefano e quello di San Giovanni Evangelista dipinto in grisaglia all’esterno del polittico dell’Agnello Mistico di Hubert e Jan van Eyck (Gand, San Bavone), inserito tra le tavole del saggio, chiarisce in modo convincente quale fosse l’attrazione culturale a cui alludeva Zeri. In seguito lo storico dell’arte ha proposto di estendere il catalogo del pittore lombardo alla Madonna allattante del Museo Poldi Pezzoli che io stesso, in seguito alle discussioni avute con l’illustre maestro, avevo proposto di attribuire a Donato de’ Bardi; il riferimento non ha retto alle obiezioni di Giovanni Romano che ha suggerito di vedere nel bellissimo dipinto un’opera precoce di Bergognone, «datant peut-être déjà des années 1470». Da allora il quadro è sospeso in quella verosimile ma indimostrabile casella attributiva: una questione quasi inestricabile di filologia figurativa che neppure l’identificazione della minuscola cimasa che in origine completava la paletta ha potuto definitivamente chiarire.

Gli esordi genovesi del pittore sono stati riconosciuti da Zeri nei quattro Santi dell’Accademia Ligustica di Genova: Caterina, Giovanni Evangelista, Giovanni Battista, Benedetto, elementi arbitrariamente assemblati e pesantemente danneggiati (l’insieme misura 113 x 115,5 cm; ogni tavola è larga 33 cm) di un polittico di cui si ignora l’antica collocazione, che al centro doveva probabilmente includere l’immagine della Vergine con il Bambino. Le osservazioni dello storico dell’arte relative alle stringenti analogie che collegano i tipi fisionomici delle quattro figure al trittico di New York sono del tutto convincenti e reggono sostanzialmente ancora oggi, nonostante alcuni studiosi abbiano visto in quest’opera un prodotto epigonico, «troppo solidamente legato a fatti locali di ultimo Trecento (fra Taddeo di Bartolo e Nicolò da Voltri) per un pittore lombardo di nascita e di formazione». Zeri rimarcava la presenza delle medesime, splendide aureole, eseguite con «i medesimi ferri, [la] stessa cura nell’esecuzione e nella stesura delle pennellata, con il medesimo risultato di lucidità netta, precisa, quasi miniaturistica». Il volto dolce e melanconico della santa Caterina, le ciocche dei capelli ripartiti sui due lati del capo, la resa anatomica della mano che regge delicatamente la palma del martirio sono motivi comuni al dipinto del Metropolitan e rendono evidente il rapporto tra le due opere. È vero che rispetto alla seducente eleganza della principessa orientale, i santi maschili che le fanno compagnia, pur dipinti con una analoga eccellenza di mestiere, rivelano una impostazione più arcaica. Per la figura di san Giovanni Battista i modelli di riferimento sono le invenzioni di Taddeo di Bartolo, attivo in Liguria in almeno due occasioni (dal 1390/1391 al 1394, e nel 1397: Battesimo di Cristo in Santa Maria Assunta a Triora); è verosimile che in Liguria Donato de’ Bardi, confrontato al duraturo successo delle grandi macchine d’altare di Taddeo di Bartolo, dei pittori pisani e degli emuli tirrenici, abbia integrato alcune formule locali. Le indagini riflettografiche condotte sulle tavole dell’Accademia Ligustica hanno rivelato un comune «disegno sottostante di puro contorno, sottile e lineare, privo di tratteggi volumetrici e di acquarellature»; i tratti marcati con cui sono definiti i volti dei santi maschili sono stati ottenuti sovrapponendo alla preparazione chiara e al disegno lineare toni più scuri, e non è escluso che questa maniera più espressiva, che riappare con altra intensità umana in alcuni brani della Presentazione di Gesù al tempio, sia in questo caso la spia della presenza di un collaboratore: forse, come suggerisce Clario Di Fabio, Boniforte de’ Bardi, fratello di Donato. Il problema dell’autografia del ricomposto dossale di Genova è legato a quello della documentata presenza ligure del pittore pavese. Due illuminanti recenti scoperte hanno consentito di anticiparne sensibilmente la data, rispetto a quanto era stato reso noto da Alizeri. Il nome di Donato («nato Iohano li de Bardi, scolari papiensi») è registrato a Pavia tra quelli degli studenti autorizzati a ricevere la tonsura clericale e gli ordini minori; anche se sorprende l’esordio di una carriera ecclesiastica probabilmente abbandonata in seguito, non vi è ragione di dubitare dell’identità del soggetto. Altrettanto probabile è che il «magistro Donato de Papia» con bottega nel rione dei Banchi a Genova, ricordato in un documento savonese del 1405, sia proprio il pittore che sottoscrive il trittico di New York e che pone con orgoglio, intorno al 1450 o poco prima, la propria firma sulla Crocifissione di Savona.

Alla luce di questi nuovi elementi documentari è tentante riconoscere gli esordi o quanto meno le premesse dell’attività del pittore nella preziosa Madonna con il Bambino, santa Caterina da Siena e un devoto certosino della collezione Lehman al Metropolitan Museum di New York, già attribuita a Cristoforo Moretti e progressivamente avvicinata al nome di Donato de’ Bardi negli studi recenti. Il monaco che la santa senese avvolge con il proprio manto è stato identificato in Bartolomeo Serafini da Ravenna, priore della Certosa pavese dal 1397 al 1409, al quale la mistica senese avrebbe donato la propria cappa, lasciata alla morte del frate (1413) alla Certosa di Pavia. Come ammette Stefania Buganza, la restituzione del prezioso dipinto a Donato de’ Bardi (cui lei stessa aderisce) non «è di immediata evidenza, [ma] può aiutar ci a riempire lo spazio che dalla Madonna Lehman porta al sofisticato trittico di New York, la Madonna con il Bambino dell’Arcivescovado di Genova»: un’opera riferita giustamente da Filippo Todini al pittore pavese che conserva, nonostante lo stato di conservazione molto compromesso, una forza espressiva struggente. Che sia questa la sequenza degli inizi di Donato de’ Bardi o che la sua restituzione comporti qualche ulteriore ritocco, è certo che le nuove acquisizioni comportano un leggero slittamento cronologico della parte più antica del catalogo. Poco dopo il trittico del Metropolitan Museum, che non sembra superare gli anni Venti del Quattrocento (Zeri lo collocava «nel decennio tra il 1430 e il 1440, o forse anche poco prima») dovrebbero porsi la Madonna con il Bambino dell’Arcivescovado e i quattro Santi dell’Accademia Ligustica. La fondamentale levitazione maturata dal confronto con la pittura del nord Europa, conosciuta tramite gli eletti esemplari presenti a Genova nella prima metà del secolo, cade probabilmente nel quarto decennio.
La Presentazione di Gesù al tempio rappresenta lo snodo di questa colta trasformazione che, a mio parere, non necessita per essere spiegata un viaggio di apprendistato in Provenza o nei territori del duca di Borgogna. Nelle opere compiute nell’ultimo decennio della sua vita (i Santi Ambrogio, Giovanni Battista, Girolamo, Stefano e la Crocifissione di Savona), Donato de’ Bardi si accosta con maggiore partecipazione ai grandi modelli del nord, da Jan van Eyck a Petrus Christus, ed è allora, prima del 1447, che il pittore avrebbe potuto percorrere contrade forestiere, in Lombardia o nei territori che con i Visconti e subito dopo con gli Sforza intrattenevano relazioni commerciali, politiche e di cultura. Ma siamo qui in un ambito di ipotesi forse fantasiose, che, come altri aspetti ancora misteriosi del magnifico pittore, è prudente accantonare in attesa della scoperta di nuovi, dirimenti, elementi.
Nota: Il saggio è tratto dal catalogo “Solo una questione di Luce. L’Italia e il fascino delle Fiandre tra Quattro e Cinquecento”, a cura di Mauro Natale, pubblicato dalla Galleria Carlo Orsi in occasione dell’omonima mostra, aperta al pubblico tra il 27 novembre 2024 – 31 gennaio 2025.
July 24, 2025