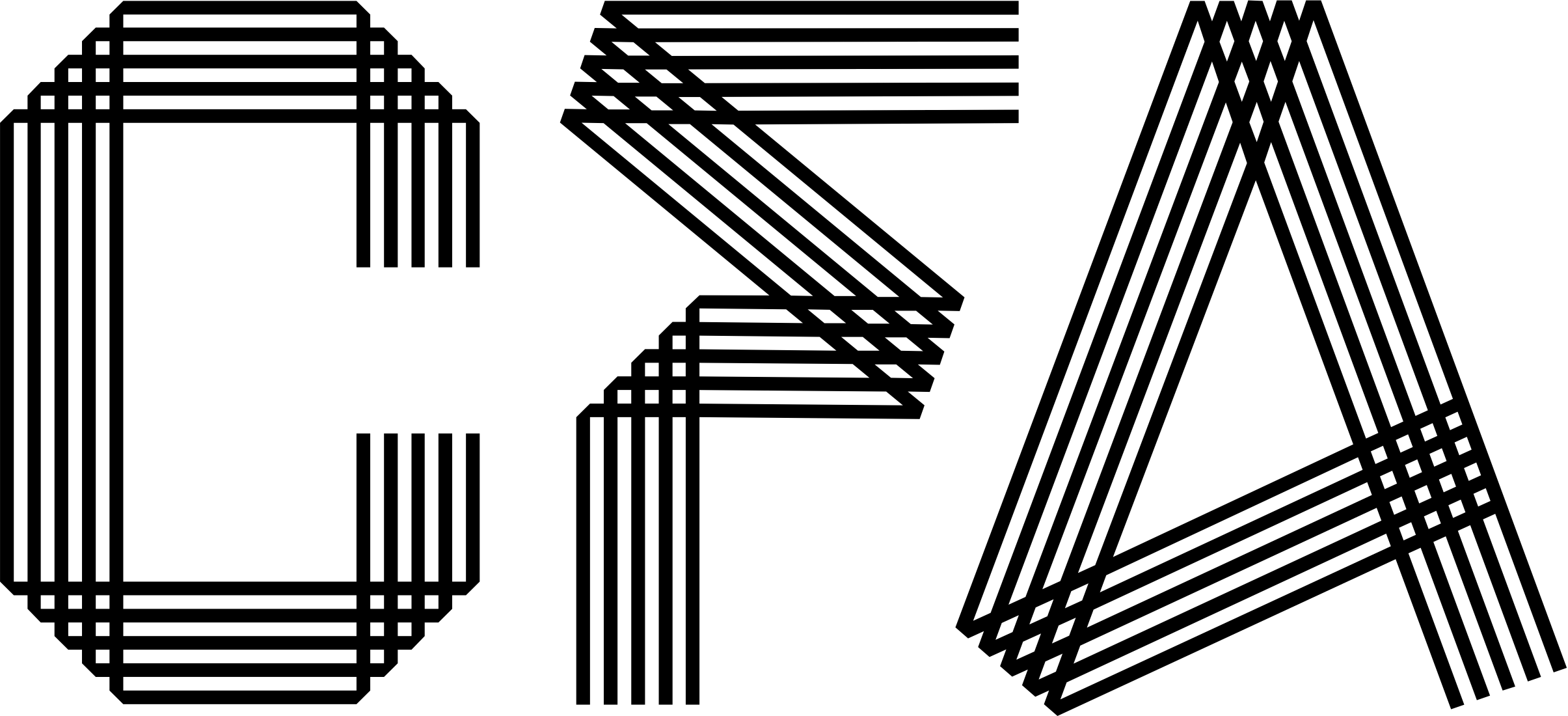Florence Carr: sentimento e simmetria
L’arte di Florence Carr di custodire, ridimensionare e compilare riecheggia i processi della memoria stessa. Anche la reminiscenza può essere tecnica.
Da qualche parte tra le pagine 196 e 226 del primo volume delle “Gesammelte Werke” di Freud si può trovare il racconto di un paziente – una donna, come nella maggior parte dei suoi casi clinici – che si dice sia passata dall’enumerare compulsivamente le sue fantasticherie erotiche al contare, con uguale fissazione, i listelli del pavimento di legno di casa sua. Potrebbe trattarsi solo di una diceria, diffusa da una nota a piè di pagina in un remoto articolo. Non riuscendo a trovare una traduzione del libro, scoraggiata dalla mia scarsa conoscenza del tedesco, mi è rimasto solo l’aneddoto. Eppure a volte mi chiedo ancora, che aspetto avevano quei listelli?
Graffiati, un po’ danneggiati dal tempo, dal passare dei giorni, dai passi. Alcuni hanno una tonalità diversa, una leggera variazione di colore. Sono irregolari, specifici: uniformi nelle dimensioni ma singolari nelle crepe, con le loro venature che scricchiolano attraverso il legno. Sembra che ogni listello abbia una sua storia. Gli assemblaggi di parquet di Florence Carr funzionano secondo una logica interna che svela una piastrella dopo l’altra, scomponendo e ricostruendo la loro forma da pavimenti di recupero, poi riorganizzati con nostalgia geometrica. Nascono da unità singolari, interrompendo un terreno comune, dividendolo in sezioni che si disperdono e si riecheggiano a vicenda: un patchwork a strisce che opera attraverso la sineddoche, ogni segmento punta verso l’altrove di una casa, un’abitazione, un cantiere che non esiste più e che può essere rintracciato solo attraverso frammenti. Sembra essere all’opera qualcosa di simile alla formula di Hanne Darboven per la creazione di sistemi distruzione-struttura-costruzione (1). Un’aritmetica di decomposizione e ricreazione; una trasfigurazione; lacerti di parete provenienti da pavimenti diversi, arazzi di legno che coniugano tempo e spazio, bilanciando il sentimento con la simmetria. In questo modo, l’arte di Florence Carr di conservare, ridimensionare e compilare fa eco ai processi della memoria stessa. Anche la reminiscenza può essere tecnica.

Queste opere riflettono e al tempo stesso si rivolgono alla nostra tendenza a “colmare i vuoti”, mi dice Florence Carr, e lo fanno con una esplicita provocazione. Le sue opere sono interdette dai pezzi mancanti; una lacuna resa ancor più evidente da un’uniformità di dimensioni che richiede di essere colmata. Assenze; ingressi – fungono da entrambi, i loro contorni delineano piccole finestre che invitano a sbirciare. Carr scolpisce forme simili a dispositivi di scrutinio; qualcosa attraverso cui spiare che si apre come un buco della serratura (Spatterdock, 2024), alludendo all’impulso scopofilico attraverso una grammatica visiva di ripetizione e trattenuta. Eppure qui la nostra vista è bloccata, ostacolata da tessuti tirati come tende. L’occhio è catturato da un modulo, “occhio bloccato nella griglia” (2), un motivo floreale o jacquard, che scruta attraverso l’armatura esterna nella morbida architettura (3) del domestico. Gli interstizi del legno e del tessuto evocano una memoria materiale che è essa stessa intrecciata in reti sistemiche: è storica ed è anche legata al genere. Questo contrasto nelle tecniche artigianali parla di una scala di valori, ponendo al centro dell’attenzione, o al centro della scena, questioni a lungo considerate minori perché codificate come “femminili”. Carr sovverte discretamente questo concetto attraverso un’operazione di inversione; spoglia gli ornamenti dal livello superficiale per collocarli in profondità, dove il decorativo funge da spina dorsale e struttura dell’opera, che a sua volta veste la stanza, ne abbraccia i contorni, proteggendo la parete e i suoi angoli (Fall, 2023). E questo sottile arricchimento dello spazio sembra ancora una volta riecheggiare lo spessore della memoria, poiché anche la memoria si accumula in strati, strati di ricordi e affetti sovrapposti in modo da proteggere.


Una parte importante delle opere di Florence Carr prende quindi in prestito dal palinsesto, rivelando frammenti di un testo precedente nascosto sotto la superficie finale. Sono private, in qualche modo codificate; trasmettono un atteggiamento che parla al nostro gusto per la decifrazione e l’intrigo. C’è un senso di gioco in queste tele che ricordano il Kapla, “sistemi che posso vedere ma non analizzare” (4), le cui lacune fungono da indovinello da risolvere, da segreto da svelare. “Riempire gli spazi vuoti” diventa quindi una provocazione, un incentivo a riempire, a completare attraverso l’esame o la libera associazione. Di fronte agli assemblaggi di Carr, la mia mente torna alla paziente freudiana e al suo parquet; penso alle sue curve, ai suoi graffi, alla sua potenziale sensualità. Comincio a contare ogni tessera come lei contava i suoi desideri. Penso a questa frase della poetessa Lisa Robertson: “Ogni sarta vorrà toccare con mano le espressioni interiori delle cuciture” (5). Di donne di cui una volta ho letto le storie ma di cui non ricordo bene i nomi: sarte-spie che tessono messaggi in codice Morse da leggere tra i fili, usando la loro facciata femminile come camuffamento.

Accanto alle immagini e alle citazioni che emergono in forma frammentaria, esiste questa tensione nel cercare di dare un senso a tutto ciò, nell’intrecciare la paziente e la sarta nella trama di un testo, attraverso una logica esplicativa che non lasci alcun vuoto. Mi sembra che il lavoro di Florence Carr risponda a questo bisogno di dare un senso; ciò che l’artista definisce anche “chiusura”, un concetto della teoria della Gestalt che indica la tendenza del cervello a percepire un insieme anche quando mancano delle parti. Il lavoro di Carr risuona come un esercizio di sintassi. Un tentativo di formalizzazione. Dare una forma, ci ricordano i suoi assemblaggi, è un’operazione attraverso la quale si modella e si creano contorni – ed è così che funziona anche il linguaggio: ogni parola definisce attraverso dei limiti, creando un’architettura grafica e fonica, una rete in cui ciò che è sfocato viene reso nitido attraverso una serie di segni. Eppure queste opere non cedono al desiderio di coerenza narrativa. Funzionano piuttosto attraverso il frammentario – ciò che è tagliato, punteggiato. L’artista crea un’erotica dello sguardo e del ricordo che funziona attraverso le sue parti mancanti, che ammette di essere sempre parcellizzata, incompleta, interrotta. Questo forse si riflette anche nel modo in cui Carr concepisce l’incontro con l’opera d’arte nello spazio espositivo.

C’è un fattore temporale nella sua scelta dei materiali; l’artista seleziona in base a ciò che assorbirà e registrerà il passare del tempo, la luce che frammenta uno spazio – una patina fatta di “tracce lasciate su oggetti e spazi e che fungono da forma di informazione grafica”, come mi scrive. Entrare nello spazio espositivo assume così l’aspetto di un’irruzione, un’improvvisa intrusione nello spazio, un tuffo in medias res (per usare un’altra analogia letteraria) nel ciclo di vita frammentato della materia. I lavori recenti approfondiscono questo impegno con il linguaggio e il testo, isolando i riferimenti letterari che interferiscono con il flusso narrativo. Impresso sulla pelle, il termine continu-um è ironicamente scritto con il trattino in Continuum (day), mentre Continuum (night) sembra raffigurare una costellazione, che è anche un dinkus o asterisco, ovvero simboli tipografici composti da tre stelle che segnalano una pausa o un’ellissi all’interno di un testo. Esprimendo questo concetto direttamente nel titolo, si estendono, sempre sulla pelle, una serie di parentesi che non contengono alcun contenuto; e in questa vicinanza compositiva, in questa assenza di interferenze, potremmo anche riconoscere un paio di lune crescenti, o la forma di un occhio, che discretamente ci fa l’occhiolino.
September 3, 2025