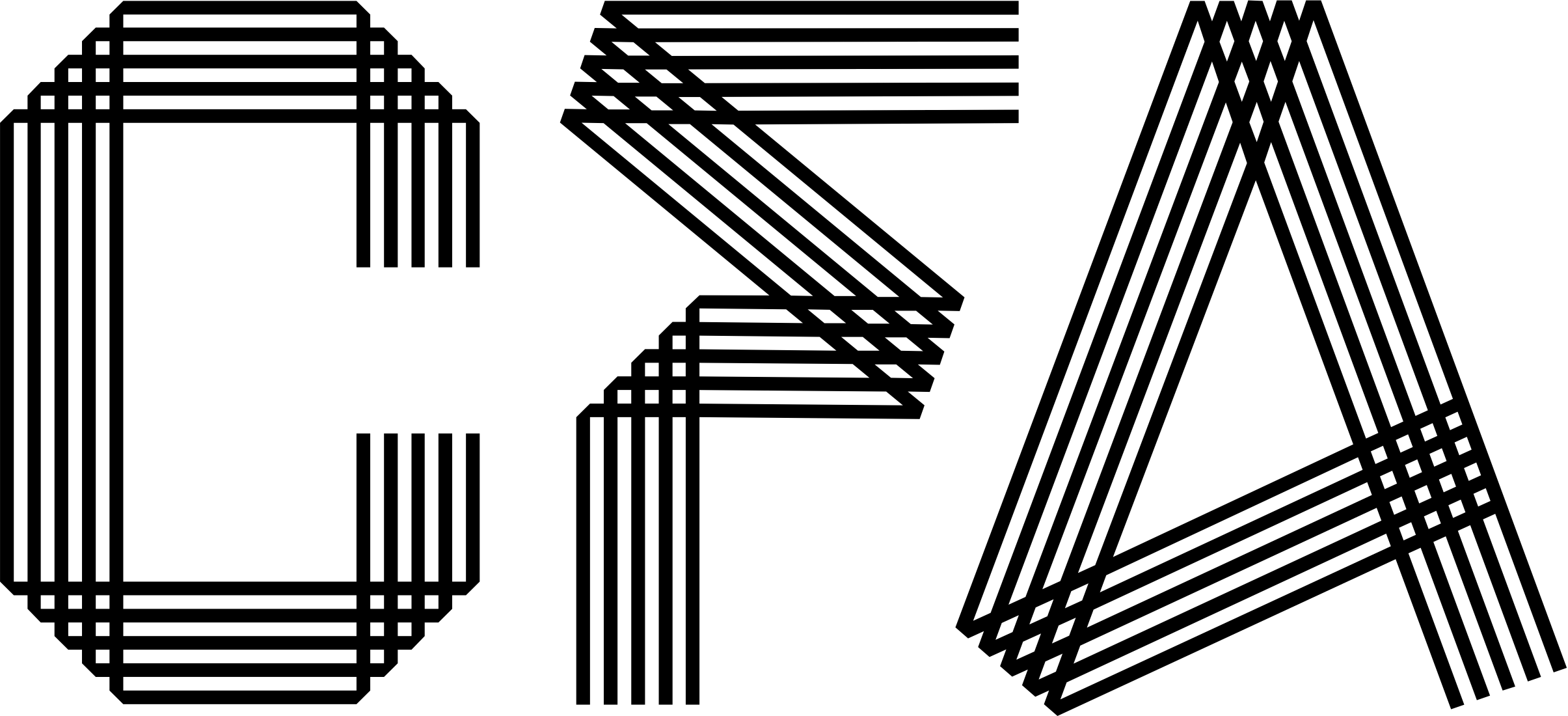Il tempo dell’ascolto in Chantal Akerman e Sonia Wieder-Atherton
Il dialogo tra Chantal Akerman e Sonia Wieder-Atherton unisce immagine e musica in un tempo di ascolto condiviso.
“Le temps est ce qui permet à la musique de blesser sans toucher.”¹
Chantal non amava le parole superflue. Nemmeno Sonia. Si sono incontrate in quella zona di silenzio che precede un suono, o un’inquadratura. “Con Chantal, non c’era bisogno di spiegare: ci ascoltavamo nel vuoto,” scrive Sonia Wieder-Atherton.⁶ Una regista e una violoncellista: due mestieri che toccano la stessa materia. Il tempo. Una tiene ferma l’inquadratura finché il reale non cede. L’altra, tende l’arco finché il suono non si fa corpo. Si sono riconosciute nel gesto di trattenere. Nel montaggio come nel respiro.

Non tutte le relazioni artistiche nascono da un progetto. Alcune si annunciano come un’eco, una vibrazione, un’interferenza. È accaduto così tra Chantal Akerman e Sonia Wieder-Atherton: non c’è stato un programma da condividere, ma un tempo da abitare. Un tempo da ascoltare. Entrambe cercavano qualcosa che non si può afferrare direttamente: un respiro che si trattiene, un silenzio che diventa sostanza, una durata che non chiede compimento. Il cinema di Akerman e la musica di Wieder-Atherton non si completano a vicenda: si sfiorano, si attendono, si interrogano senza fondersi.
Akerman ha sempre diffidato della narrazione. Il suo cinema non racconta, trattiene. Monta il tempo come si monta una soglia.² I suoi piani fissi non sono semplici inquadrature ma dispositivi percettivi, modalità per esperire la materia temporale, per farla vibrare. Nelle immagini che riprendono l’attesa, l’immobilità, la ripetizione quotidiana, qualcosa si incrina: un gesto minimo disloca il senso, un’inquadratura apparentemente neutra rivela un’interiorità in tensione. È in questa disposizione dell’ascolto — nella possibilità che l’immagine pensi, come scriveva Deleuze — che si inserisce il suono di Sonia Wieder-Atherton.
Il violoncello lavora in modo simile: sottrae, distilla, sospende. La sua musica non accompagna il film: lo abita lateralmente, come una presenza discontinua. Non spiega, né sostiene. Si muove come un corpo autonomo che attraversa le immagini, lasciando un’impronta lieve e necessaria. Roland Barthes parlava della “grana della voce”, di quel punto in cui il suono si fa corpo, carne, eros.³ Il violoncello, nel gesto di Wieder-Atherton, ha proprio quella densità tattile, organica, che si deposita sul film come una seconda pelle: non lo illustra, ma lo incide. In questo senso, le loro pratiche convergono. Entrambe operano sul margine, il margine dell’emozione, del linguaggio, del ricordo. E se il film diventa una forma d’ascolto, la musica diventa una forma di visione. Il tempo è ciò che entrambe elaborano, scavano, aprono: un tempo non misurabile, non lineare, che ha a che fare con la durata bergsoniana⁴, con l’esperienza vissuta più che con la sequenza degli eventi.
Jean-Luc Nancy scrive che ascoltare significa esporsi.¹ Non si tratta di ricevere un suono, ma di lasciarsi raggiungere da ciò che arriva. È in questo “essere esposti” che il cinema di Akerman e la musica di Wieder-Atherton si ritrovano: come aperture vulnerabili, come gesti che non cercano senso, ma che lo rendono possibile. Peter Szendy, teorico dell’ascolto, ricorda che accogliere il suono è sempre condividere un rischio: quello di essere modificati.⁵ Ogni film, ogni brano, è dunque una messa in gioco della forma e del confine. Un’alleanza fondata sull’intermittenza, sulla fiducia, sulla latenza.
In Là-bas (2006), Akerman filma da un appartamento chiuso a Tel Aviv. L’esterno entra solo filtrato, attraverso le persiane. Non c’è azione, solo la voce della regista che medita sull’identità, sull’esilio, sulla madre sopravvissuta alla Shoah. Il film è una stanza, un confine. In questo spazio chiuso e oscillante, il violoncello di Wieder-Atherton si insinua come una linea d’aria. Non interrompe. Non addolcisce. Fa vibrare le pareti. Le tende. L’attesa. È un suono che non cerca l’effetto ma la soglia: quella che separa ciò che si può dire da ciò che resta in sospeso. Non accompagna la voce, ma la circonda. La custodisce.
“Io ho cercato di ‘sentire’ come suonare quel che non potevo vedere.”⁶ È questa vibrazione riflessa, più che l’enfasi, a segnare il nucleo della loro intesa.

Già in D’Est en musique (2005), concerto-immagine concepito a quattro mani da Akerman e Wieder-Atherton a partire dal film D’Est (1993), questa alleanza tra immagini e suono si fa dispositivo scenico. Il formato ibrido — a metà tra concerto, proiezione e installazione immersiva — mette il tempo alla prova in modo ancora più radicale: i piani fissi e i lunghi travelling dell’Europa dell’Est dopo la caduta del Muro sono attraversati da una costellazione di musiche che, nella versione del 2005, portano soprattutto la traccia dei compositori russi. Oggi, nella rilettura che Sonia dedica allo stesso progetto, quella trama si apre a una “mosaïque musicale” più ampia, come gesto di riconoscimento verso l’Ucraina e verso tutte le vite anonime che abitano quelle immagini. La partitura si trasforma senza rinnegare il pensiero originario condiviso con Chantal, accogliendo l’urgenza della storia recente e mostrando quanto il loro lavoro comune abbia sempre intrecciato, senza gerarchie, arte e vita.
Una soglia risonante di questa poetica dell’ascolto è il breve film Trois strophes sur le nom de Sacher (1989), in cui Chantal Akerman filma Sonia Wieder-Atherton nell’atto di eseguire l’omonimo brano di Henri Dutilleux. Composto tra il 1976 e il 1982, Trois strophes sur le nom de Sacher nasce come omaggio a Paul Sacher, il grande direttore d’orchestra svizzero, in occasione del suo settantesimo compleanno. Fu Mstislav Rostropovich a immaginare questa costellazione di opere per violoncello solo, invitando dodici compositori a scrivere brevi brani costruiti su un crittogramma musicale ricavato dal nome “Sacher” (S = mi♭, A = la, C = do, H = si, E = mi, R = re). Ne nacquero miniature sonore dense, ellittiche, dove la forma obbedisce più al mistero del suono che alla retorica della composizione.
Dutilleux, con il suo stile rarefatto e intensamente timbrico, compose tre strofe autonome ma legate da un respiro comune: la prima interrogativa e raccolta, la seconda lirica e sospesa, la terza più incalzante, attraversata da tensioni sottili che sembrano sgretolare la linea melodica. È un’opera che non racconta, ma circola; che non costruisce, ma sfibra. Akerman ne accoglie la voce con uno sguardo di pari rigore e delicatezza. Non c’è narrazione, non c’è dramma. Solo il corpo della musicista, l’arco che si solleva, il suono che affiora — e, sullo sfondo, l’eco di una vita quotidiana che scorre altrove, dietro una finestra, in una luce.
La macchina da presa non accompagna: si dispone all’udito. Ogni gesto musicale è filmato come un fenomeno percettivo, una materia temporale che include l’aria, l’attesa, l’intensità del silenzio. La musica di Dutilleux, tanto discreta quanto esigente, trova in Akerman una regista capace di offrirle un tempo visibile senza mai ingabbiarla. Il film stesso diventa variazione, non sul tema, ma sull’attenzione sonora. Un’attenzione che si fa immagine. Come il brano da cui prende il titolo, Trois strophes sur le nom de Sacher, il film è breve solo in apparenza. Dentro la sua durata contratta si apre uno spazio più ampio, dove il suono diventa tempo e l’immagine una soglia. In quello spazio temporale ridotto, il cinema aveva già imparato ad ascoltare come la musica. Ma in seguito, con Mémoires, quell’ascolto si è fatto corpo, spazio, presenza. Non più solo un’immagine che accoglie il suono, ma un tempo condiviso che lo rende visibile.
È questa qualità dell’eco, più che dell’enfasi, che caratterizza la loro collaborazione. In Mémoires, concerto-performance nato nel 1999 e presentato in diverse versioni tra Parigi, Marsiglia e Gerusalemme, le immagini che Akerman affida allo spazio scenico non sono narrative, ma interstiziali. Volti, mani, architetture interiori. La musica attinge a fonti arcaiche e popolari, ma le trasfigura in qualcosa di altro: un paesaggio emotivo, una liturgia spoglia, un atto di trasmissione non genealogica ma sensibile. In un tempo dominato dalla riproduzione e dalla dispersione, Mémoires sceglie la forma rara dell’apparizione. Non è un’opera fissata, ma uno spazio performativo che si riapre ogni volta, come un gesto che si rinnova nell’ascolto. Le sue esecuzioni — mai identiche, mai ripetute — si sono articolate in una costellazione di eventi fragili e intensi, che hanno attraversato l’Europa e il Nord America come veglie mobili del suono e della memoria. Alla Philharmonie di Parigi, in festival come il New Horizons di Wrocław, il RIDM di Montréal o il FIAF di New York, Mémoires è comparso in forma di concerto, di installazione, di tributo silenzioso. A volte precedeva la proiezione di un film; altre volte ne prendeva il posto, lasciando che la musica dicesse ciò che l’immagine non osava più mostrare.

Nel 2020, con Chantal?, Wieder-Atherton ha trasformato questa pratica in un omaggio itinerante, in cui suono, parola e frammenti filmici si intrecciano come relitti affettivi di un’alleanza artistica e umana. In tutti questi momenti, il violoncello non si limita a suonare: occupa lo spazio scenico come un corpo intermedio, attraversato da memorie non sue, da lingue dimenticate, da echi sopravvissuti. Non si dà concerto, ma presenza. Non si dà replica, ma ritorno. Ogni esecuzione è un atto di resistenza contro l’oblio: un tempo dell’ascolto che si fa ospitale, vulnerabile, vivo.
Particolarmente intensi sono i passaggi in cui Wieder-Atherton lavora sulla trascrizione per violoncello della musica liturgica ebraica, trasmessa oralmente dai cantori dell’Europa orientale e raccolta attraverso un lungo lavoro di ricerca tra Gerusalemme e Parigi, ascoltando archivi orali, registrazioni private, testimoni sopravvissuti. È un lavoro che prende avvio quando Chantal Akerman le chiede di comporre la musica per Histoires d’Amérique, desiderando che il suo violoncello fosse “un’altra voce” capace di unirsi alle voci di tutti i personaggi del film. Non solo soggetti sonori, ma documenti dell’anima: canti bifronti, che custodiscono insieme la gioia e il lutto, l’ironia e il lamento. Vengono scelti canti di veglia, di esilio, di infanzia, in cui la voce originaria viene trasposta nel violoncello senza perdere la propria vulnerabilità.
Questi brani portano dentro di sé una geografia spezzata: la Galizia, il ghetto di Varsavia, Vilnius, Odessa. Cantano dell’amata lontana, dell’inverno che non finisce, della madre perduta, della preghiera interrotta. Sono forme liriche di sopravvivenza, dense di immagini quotidiane e cosmiche insieme. Il violoncello allora diventa voce, prende il posto del ḥazzān, trasforma la melodia in memoria incarnata. Le inflessioni modali, le micro tonalità, l’emissione spezzata, l’arco che imita l’incertezza della voce viva: tutto concorre a fare di questi brani non una rievocazione, ma una presenza. La musica non cita, ma testimonia e ogni brano è un luogo sensibile del passato: non illustra la memoria, la fa accadere di nuovo.
Sono canti che appartengono a un patrimonio non codificato, dove la distinzione tra sacro e profano, fra lutto e festa, fra linguaggio e suono, è continuamente messa in tensione. Vi si trovano ninne nanne per bambini mai nati, lamenti funebri in forma di dialogo, ballate d’esilio che parlano di distacchi, partenze forzate, assenze. Non è raro che una melodia apparentemente giocosa contenga al suo interno una fenditura, una frattura — come se la tonalità stessa sapesse ciò che la parola non può dire.
Wieder-Atherton non trascrive: traduce nel corpo. L’arco non accompagna il canto, ma lo precede e lo segue. La sua gestualità, lenta, porosa, restituisce il ritmo irregolare della voce che trattiene un pianto o insegue un ricordo. Qui il violoncello, con le sue vibrazioni profonde, riproduce l’instabilità fonica dello yiddish: le krekhts (soffi, sospiri), le schleps (slittamenti), i tremolii che rendono la voce umana anche quando è rotta. In alcune sequenze di Mémoires, queste melodie sembrano sorgere non da una partitura, ma da una zona interiore, come se la memoria non fosse più contenuta in un archivio, ma passasse attraverso il corpo dell’interprete. Così il canto non viene riprodotto, ma riattivato e la sua trasmissione non è filologica, bensì postuma. Non si tratta di ricostruire un’origine, ma di offrirle un nuovo tempo in cui accadere.
Alcuni brani evocano la tradizione del nigun, il canto spirituale privo di parole tipico della mistica chassidica, in cui la ripetizione estenuata di sillabe senza senso (yai dai dai, bim bom bom) mira a sospendere il linguaggio per raggiungere un punto di espressione prelinguistica. Wieder-Atherton reinterpreta questi motivi come varchi nel tempo storico, come spiragli di un’arcaica memoria acustica. La musica diventa un rituale muto, un gesto liminale che collega ciò che non può più essere detto a ciò che chiede ancora udienza. In questa prospettiva, Mémoires non è né performance né concerto, ma veglia. Un luogo in cui il riverbero di voci cancellate si fa presenza sonora. Dove il passato non viene illustrato, ma ospitato. Dove la memoria non è né documento né testimonianza, ma fenomeno acustico intermittente, materia che ritorna in forma di vibrazione, di timbro, di lacerazione musicale.

Questo rapporto tra memoria e suono affonda le sue radici anche nella formazione stessa di Wieder-Atherton. A diciannove anni parte per Mosca, dietro il “rideau de fer”, per studiare con la violoncellista e pedagoga Natalia Chakhovskaïa al Conservatorio Čajkovskij. In quei due anni e mezzo di apprendistato, tra il gelo, la difficoltà della lingua, le privazioni quotidiane, impara a pensare il violoncello come una voce: il rapporto alla corda, la tenuta dell’arco, l’intensità dell’interpretazione diventano un modo di abitare il tempo più che di eseguire una partitura. È un viaggio iniziatico che continuerà a nutrire il suo lavoro, tanto più dopo la morte della maestra e dopo l’aggressione dell’Ucraina, quando quei ricordi si riaccendono come presenze irriducibili.
Da questa esigenza di testimoniare nasce il progetto Carnets de là-bas, creato insieme a Clément Cogitore: un racconto in forma di concerto in cui la voce, registrata o dal vivo, di Sonia che legge i suoi taccuini sovietici si intreccia con “ombre di violoncello” da lei stessa registrate, il canto del violoncello in scena, un montaggio video di vere e false immagini d’archivio, musiche di Šostakovič, Boris Čajkovskij, Bloch, Scelsi, Schubert, Couperin, Bach, Monteverdi. Lontano dall’illustrare il testo, il lavoro di Cogitore apre “punti di fuga” che rispettano l’intimità dei ricordi, scegliendo frammenti che sfiorano la memoria senza mai possederla. Anche qui, come con Akerman, passato e presente, assenza e presenza, documento e invenzione si ricompongono in un gioco di risonanze, dove ciò che conta non è la cronologia ma la vibrazione condivisa di un tempo vissuto.
In questo contesto, la musica diventa un atto di cura e di restituzione. Non si limita a evocare un’origine perduta, ma apre un luogo di percezione sonora dove l’eredità e la fragilità convivono. Akerman, con la sua regia invisibile ma operante, non sovrappone immagini illustrative: le lascia emergere. Le lascia vibrare in ascolto, nel suono, col suono. Si crea così un gesto condiviso di ospitalità affettiva, in cui il lutto e la memoria non sono mai chiusi, ma continuamente riaperti. L’immagine, in queste opere, non è mai un documento, è una sopravvivenza, un ritorno in forma di differenza. Come scrive Georges Didi-Huberman, l’immagine è un intervallo tra il visibile e il non visto, tra il passato e il presente.⁷ Non restituisce il tempo: lo sfibra. Lo mette in crisi. Akerman lavora con queste immagini come con resti affettivi, come con reperti. La musica di Wieder-Atherton entra in questa grammatica come una fenditura acustica: si fa polvere sonora, scarto, lacuna. “Le immagini che mi restano non sono visive, ma acustiche”⁶, dichiara.
Talvolta, il loro scambio assumeva la forma di un dialogo muto, fatto di minime intese, di sguardi trattenuti, di presenze che si sfiorano. In un’intervista recente, Wieder-Atherton ha ricordato: “Non abbiamo mai parlato di intenzioni. Chantal non spiegava. Mi lasciava spazio. Piuttosto che dirmi cosa voleva, mi offriva un vuoto da abitare.” Ed è forse proprio da quel vuoto che nascono alcune domande inevitabili per chi ascolta il suo lavoro oggi, con attenzione non solo poetica ma anche tecnica. Il gesto dell’arco, che sembra spesso non produrre il suono ma trattenerlo, quasi scavarlo dal silenzio, appare come un delicato equilibrio tra tensione tecnica e latenza espressiva, un tempo minimo tra il respiro e la vibrazione in cui qualcosa accade e resta inafferrabile. Molti dei brani che Sonia interpreta, soprattutto quelli yiddish o privi di parole, sembrano non avere un’origine fissa ma emergere da uno spazio acustico interiore; portano in sé fratture, sospensioni, timbri spezzati che l’interprete assume e metabolizza. L’arco, l’intonazione, il peso, diventano allora i luoghi in cui una memoria non scritta, trasmessa come una ferita, trova una forma provvisoria: non una risposta esplicativa, ma una pratica del suono che continua a interrogare chi ascolta.
Nel 2020, presentando lo spettacolo Chantal?, Wieder-Atherton ha descritto così la loro relazione: “Era un dialogo con Chantal. Con Chantal in Saute ma ville (1968). Con la sua voce che legge, i suoi gesti, i suoi silenzi, la sua danza insieme farsesca e tragica, la sua ansia che mormora piccoli motivi.” Un dialogo che non si fondava su un’intenzione da dichiarare, ma su una disponibilità reciproca ad abitare l’intervallo, l’ascolto, la latenza. Questa modalità di lavoro, fondata sull’allusione e sull’ascolto reciproco, ha generato opere che non nascono da un progetto predefinito, ma da una consonanza. Come due linee che non si sovrappongono ma si inseguono, Akerman e Wieder-Atherton hanno composto una partitura fatta di pause, accenni, gesti elusivi.
Nel loro fare comune, l’immagine non illustra la musica, e la musica non sottolinea l’immagine: entrambe si sottraggono alla subordinazione, instaurando una relazione fondata sull’asimmetria e sulla fiducia. È un modello di collaborazione in cui la differenza non è un ostacolo, ma una condizione di risonanza.

In No Home Movie (2015), film testamento, questa logica si porta all’estremo. Il titolo stesso è una torsione: ciò che resta della casa, della madre, della voce. Un film senza musica. Ma è proprio qui che la musica si fa carne. Una carne spettrale. Ogni silenzio è pieno del suono che manca. Ogni dissolvenza, una cassa armonica del non-detto. Il violoncello tace, ma vibra altrove. Lo spettro dell’ascolto resta. Resta come ciò che non possiamo smettere di sentire, anche in assenza del suono. Akerman filma sua madre nella quotidianità fragile dell’ultima convivenza. Nessuna musica accompagna quelle immagini. Ma è come se il violoncello avesse già suonato, e ora ne restasse solo l’eco. Ogni dissolvenza, ogni attesa, ogni pixel disturbato è già suono. Un suono scomparso, ma ancora vibrante. “Ogni suono che produco si rivolge a un’immagine che non c’è più. O che forse non c’è mai stata.”⁶, racconta Wieder-Atherton.
Nel loro lavoro, il silenzio non è vuoto. È composto di parole non dette. Una sostanza densa e invisibile che chiede forma. In Alexis ou le traité du vain combat, Marguerite Yourcenar dice che ogni silenzio è fatto di parole non dette. E aggiunge, con dolente lucidità, che forse è per questo che si diventa musicista — perché qualcuno deve parlare non con le parole, sempre troppo precise per non ferire, ma semplicemente con la musica.
La musica, in questa accezione, non è decorazione ma necessità. Un gesto per dare voce all’indicibile, per far parlare il silenzio senza violarlo. Akerman e Wieder-Atherton condividono l’etica di un’arte che non mostra, ma custodisce. Non hanno mai raccontato una storia. Hanno praticato uno spazio. Hanno abitato l’intervallo.
E proprio in quell’intervallo sospeso, ci hanno insegnato ad ascoltare il tempo che resta — non il tempo misurabile, ma quello che si insinua tra le pieghe dell’attesa, della perdita, della memoria. “Suonare era un modo di trattenere l’immagine, di non lasciarla scomparire del tutto,”⁶ come se ogni nota potesse farsi argine contro l’oblio, come se il suono, più delle parole, avesse il potere di custodire ciò che non è più visibile.
Maurice Blanchot scriveva che “la parola essenziale è quella che si pronuncia quando non si ha più niente da dire,”⁹ indicando forse quel punto estremo in cui il linguaggio non serve più a spiegare, ma a restare, a testimoniare una presenza fragile, eppure necessaria.
Il lavoro di Akerman e Wieder-Atherton è fatto di queste parole silenziose. Di questi accordi senza enfasi. Di questi gesti che restano, anche quando tutto tace. La musica di Sonia non accompagnava le immagini di Chantal. Le abitava, come un respiro trattenuto. Ogni nota era un filo d’assenza — tirato dal tempo, dall’esilio, dalla nostalgia — tessuto tra una stanza abbandonata e un treno in corsa.
Chantal era il fotogramma immobile; Sonia, la vibrazione che resta. Non per colmare il silenzio, ma per lasciarlo fiorire. Come se l’archetto ricordasse. Come se il violoncello continuasse a cercarla.
Ringrazio profondamente Sonia Wieder-Atherton per la generosità con cui ha condiviso ricordi, parole e musiche che continuano a vibrare nel tempo. La sua voce, incarnata nel suono, ha reso possibile questo ascolto. Un sentito ringraziamento va anche alla Fondazione Chantal Akerman per la cortese condivisione delle immagini, e per il lavoro di tutela visiva e simbolica di un’opera che continua a interrogare il nostro presente.
1) Jean-Luc Nancy, À l’écoute, Galilée, 2002, p. 16.
2) Gilles Deleuze, L’immagine-tempo, Ubulibri, 1989, p. 22.
3) Roland Barthes, “La grana della voce”, in Il brusio della lingua, Einaudi, 1988, pp. 229–236.
4) Henri Bergson, L’evoluzione creatrice, Laterza, 2011, pp. 6–10.
5) Peter Szendy, Écoute. Une histoire de nos oreilles, Éditions de Minuit, 2001, p. 73.
6) Sonia Wieder-Atherton, “Dove sono le immagini?”, in Chantal Akerman. Travelling, MAC/CCB, 2025, p. 30.
7) Georges Didi-Huberman, L’immagine sopravvivente, Bollati Boringhieri, 2007, p.152.
8) Marguerite Yourcenar, Alexis o il trattato della lotta vana, Bompiani, 1989, p. 33.
9) Maurice Blanchot, Lo spazio letterario, Einaudi, 1974, p. 93.
December 23, 2025