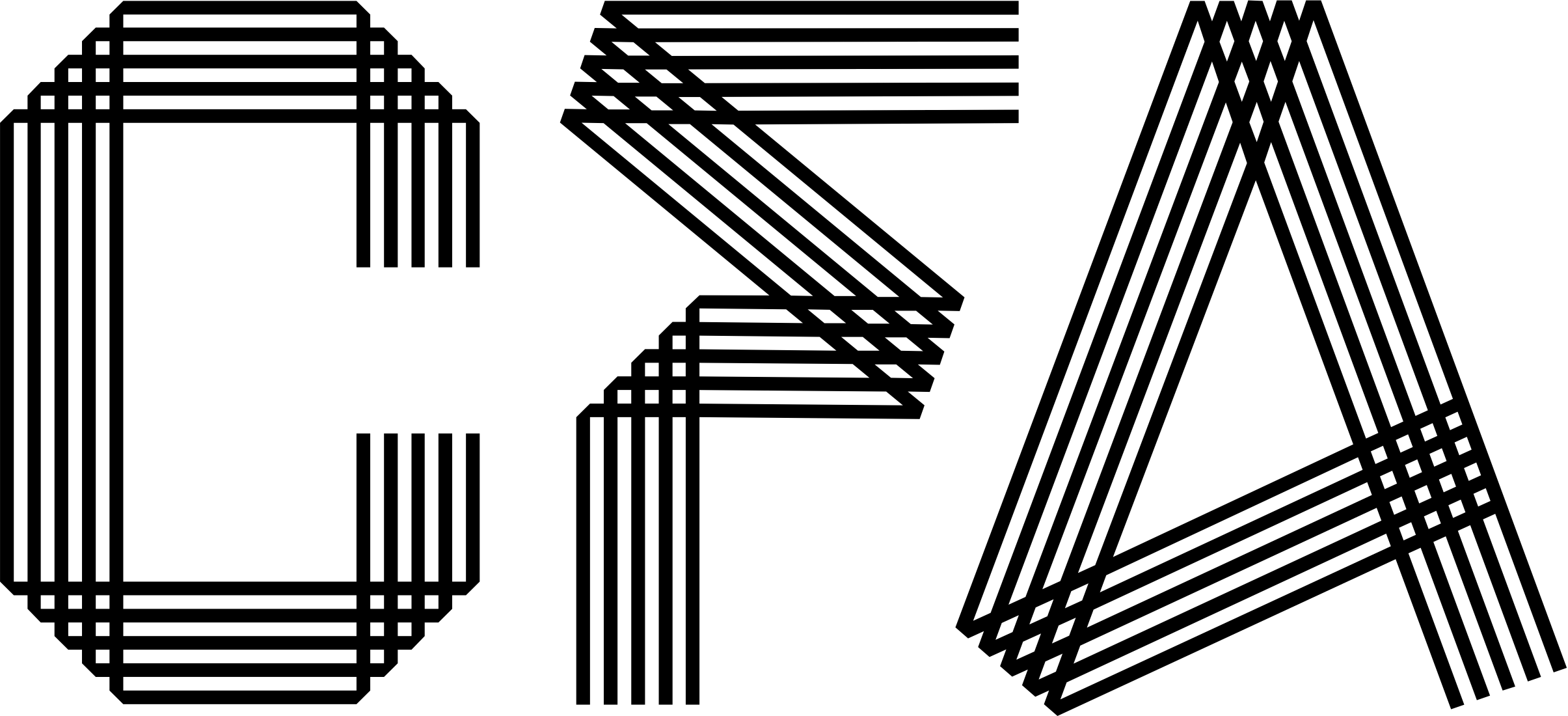A proposito della mentalità di Patrick Weldé
Trasformando la campagna in una frontiera creativa Patrick Weldé trova un antidoto ai cliché urbani e alla disillusione della moda.
Limitarsi a osservare dalla la vetrina di una galleria d’arte o dal muro di un museo i prodotti della vivace vena artistica di Patrick Weldé (n. 1992, Mulhouse, Francia) sarebbe un fraintendimento di natura simile a quello che si sarebbe commesso nel secolo scorso ritenendo De Stijl un movimento artistico, comprando un dipinto astratto di Bruno Munari, oppure una fotografia di Nan Goldin. Patrick Weldé non è un artista, un fotografo (di moda), uno stylist, e non è nemmeno un personaggio mediatico. Piuttosto, riesce a essere una sintesi di diversi ruoli, riducendoli a quel minimo comun denominatore che si chiama mentalità creativa.

‘Qualche tempo fa – ricorda Weldé – un agente è venuto da me dicendomi che avevo molto talento, ma che se volevo farmi strada nel mondo della moda dovevo smettere di fotografare parenti e amici. Non gli ho dato retta’. Per fortuna, visto che è proprio il microcosmo di un paesino di 1500 anime a due passi da Mulhouse e dal confine con la Svizzera, ad aver offerto a Weldé l’occasione di dire con le immagini qualcosa di davvero interessante riguardo al nostro tempo. ‘Sono cresciuto con il sogno di andarmene da qui, e a vent’anni finalmente sono riuscito a stabilirmi a Parigi. Ma poi ho capito che non era Parigi il posto dove mi venivano le idee migliori, e sono tornato’.

La scenografia offerta da una campagna spoglia, testardamente agricola, dal cielo quasi sempre bigio e senza ambizioni, è in realtà la metafora perfetta di quello che le città sono per molti diventate. Se non si può andare in ufficio, al ristorante, nei bar la sera, nei musei, se non si può beneficiare della straordinaria varietà umana che ogni città offre, allora perché privarsi degli spazi aperti, dei verdi e degli azzurri di un borgo di campagna, che sarà senz’altro vantaggioso, per altro, anche sul piano economico? Come abbiamo imparato qualche anno fa a Venezia da una Biennale d’Architettura, il trend di crescita in termini di abitanti delle città rispetto alla campagna non si è mai invertito nella storia, e scommettiamo che non sarà una pandemia a cambiare la regola. Così come è ragionevole pensare che non sarà una pandemia a mettere in discussione che l’arte si fa per il centro, piuttosto che per la periferia. Ma è pur vero che la campagna è uno scenario decisamente meno sfruttato dai creativi di ogni confessione, se non altro per una questione di logistica. Ed ecco dove l’intuizione di Patrick Weldé centra il bersaglio. Per quanto surreali, disadattati, scenografici possano sembrare i personaggi fotografati a Heimsbrunn, lo sfondo a cui sembrano appiccicarsi come stickers maleducati è ostinatamente reale, disadorno, anonimo, immobile, crudo, muto, persino assoluto, al punto da diventare scena nella scena e raddoppiare ogni volta la forza espressiva del soggetto. Così la campagna di Mulhouse finisce per assomigliare molto alla Baltimora di John Waters, e anche gli amici dopotutto potrebbero essere gli stessi.

Il secondo pilastro che regge l’edificio estetico eretto da Patrick Weldé è decisamente più sottile del primo, ma altrettanto efficace. Dal punto di vista fotografico Weldé si pone in modo più o meno consapevole lungo quella linea che parte da un pioniere della cosiddetta queer photography Walter Pfeiffer [qui il link alla nostra intervista con l’artista. Ndr.], passa attraverso Nan Goldin e Wolfgang Tillmans, e arriva diretta a Ryan McGinley. Rispetto a questi quattro punti cardinali l’elemento che determina l’unicità del linguaggio di Weldé va cercato nel tono antilirico, in certi casi persino distaccato, delle sue immagini più efficaci. Una delle costanti rivelate dalla personale dedicata a Weldé da Goswell Road (Fuck the system, 2016), poi seguita da Freiheit (diario fotografico in edizione limitata che raccoglie alcune delle immagini pubblicate da Weldé in un blog giovanile che probabilmente presto verrà rimosso) è la sua capacità di risultare espressivo anche senza ricorrere a lirica, dramma, o sentimentalismo zuccherino.

Si intuisce infatti che il fotografo è parte integrante della scena che ‘dipinge’ – spesso nascondendo ai soggetti la macchina fotografica o lo smartphone -, ma il suo sguardo si mantiene inaccessibile, anche quando il soggetto è Weldé in prima persona. In questo modo l’immagine diventa neutra, atemporale, libera (freiheit, appunto) dalla narrativa che finirebbe per incanalare il significato nello sbadiglio della biografia personale. Poco importa perciò sapere se uno dei personaggi più ritratti soffriva al tempo dello scatto di un male gravissimo, dal quale per grazia divina poi è guarito. E poco importa che quel blog abbia attirato sul diciottenne Weldé il caustico giudizio dei benpensanti – già, perché non bisogna dimenticarsi che la campagna è anche uno dei pochi luoghi rimasti in occidente dove esiste un pubblico benpensante da scandalizzare. L’inaccessibilità dell’autore libera l’immagine dal sovrappeso di una narrativa specifica, e così si spiega anche perché poi questa funzioni così bene nell’universo semiotico della moda, che alla vena di Weldé da qualche tempo attinge. La storia siamo noi.

All’inizio si parlava di mentalità. Ebbene, dati i due pilastri – ovvero la costante del contesto rurale autentico e l’inaccessibilità dell’autore – l’elemento che merita di essere è lo spirito con cui Weldé fotografa, che non è quindi quello di documentare una certa personalità, oppure un fatto di per sé straordinario e perciò potenzialmente meritorio della nostra attenzione. I personaggi di Weldé non sono affatto maledetti, onirici, estremi, o in alcun modo sensuali. Al contrario, la loro autenticità fa in modo che si prestino a diventare parodia di certi cliché, una parodia che possiamo anche immaginarci interpretata da quei personaggi al bancone d’acciaio di un bar di campagna; un bar dove, in questo caso, non è nemmeno necessario bere liquori dolci per provare di essere qualcuno. Forse allora quello di Weldé è davvero il canto della disillusione.

February 9, 2021